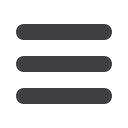

I
682
R I N A S C I T A
ma
i r r i g i d i t a s t rut tura sociale ci t tadina : i ceti
pr i v i l eg i a t i : l 'aristocrazia e i l clero e le masse
popolari oppresse e immiseri te. Degl i un i e delle
al tre i l poeta coglie le estreme forme di t i p i c i t à
e le fissa nella comi c i t à ; ma per gl i un i i l riso
non va oltre se stesso ed è acre e di s t rut t ivo ; per
le al t re i l riso scioglie le maschere che la st rut –
tura sociale impone e scopre, tramutandosi i n
commozione, l ' uma n i t à che vi si nasconde e la r i –
conduce nel vivente corso della vi ta popolare ove
t u t t o è schiettezza, concretezza, e so l i da r i e t à . I n
questo realismo concreto ed umano che coglie e
significa nomini e cose nell 'orizzonte determinato
della vi ta milanese del suo tempo, e rifiutando di
int erpre t ar l i i n vista d i un largo orizzonte sto–
r ico, l i fissa a volte e a volte, l i risolve nel riso
e ne l l ' int ima passione, sta i l senso della poetica
del Porta. Ad esso si riconduce, come vedemmo,
l'uso vivo del dialetto, e i n esso confluisce la
difesa port iana del romanticismo
« Tornand mó adess a nun, Vita de savè
Che el gran busìlles de la poesia
El consìst in de l'arte de pìasè,
E sfarle la sta tutta in la magia
De moeuv, de messedà come se voeur
Tutt i passion che gh'emm sconduu in del coeur.
E siccome % passion con Vanda innanz
Varien, baratten, fina all'infiniti,
Segond i temp, i loeugh. i circostanza
Tal e qual i so mod di cappellitt;
Cossi i
-
poetta gif ari de tend adree,
Come coi cappellitt la fa anca lee...
Han de toccamm i tasi che ne diletta,
Ciapann, come se di$
t
dove ne doeur.
Senza andò sui baltresch a tira a man
I córegh e i scuffion gregh e roraan».
Certo un cri t ico allevato al la qu i n t es senz i a l i t à
estetica, t rove r à t e rmi n i più raffinati e più r a r i ,
ma da parte d i noi milanesi va detto che per
lunghe generazioni — e oggi ancora — i l Porta
c i ha toccato i n ciò che ci di let ta e i n ciò che ci
duole> e nelPun tasto e ne l l ' a l t ro ha risvegliato
la voce e la vi ta del nostro popolo, la fede nelle
sue semplici v i r t ù e con essa — attraverso le
sue tragiche vicende — la certezza della nostra
c i t t à . E se egl i ci ascolta da quel paradiso d i
incredul i ove don Pasqual con scandalo delle due
beghine aveva visto i l Metastasio, l ' Al f i e r i e i l
Pa r i n i col «
pensee de cà
» e <c
l'ost del Falcon »,
vorremmo d i r g l i che a pochi decenni dalla sua
morte la cr i s i di tragica paral isi della sua c i t t à
fu vinta e spezzata. Nel suo seno stesso le forze
popolari , le forze del lavoro eredi dei pr i nc i p i d i
l iber t à e d i giustizia del secolo dei l umi e ardent i
del senso nuovo di indipendenza nazionale, re–
spinsero dalle barricate di Por ta Tosa le armate
austriache : a c inquant anni d i distanza, conscie
dei nuovi d i r i t t i sociali, strapparono le armi al la
reazione monarchica ; e c inquant anni dopo cac–
ciarono i n fuga invasori e oppressori nazi fascisti
i n nome della l iber t à , dell'indipendenza, del lavoro
i tal iano. Oggi esse e solo esse assicurano al la
pat r ia la pace, i l vivere libero e l 'aperto avvenire
d i civi l tà e d i cultura,, contro g l i ant ichi e nuovi
avversari. E ' tempo per una nuova epica poesia
del popolo lavoratore ' milanese ma, per quanto
diversa essa s a r à , i suoi accordi s'intoneranno su
quelli così l imp i d i e umani sbocciati al la « scoeura
de lingua del verzee ».
ANTONIO BANF I
Omaggio a Matisse
La morte dì Matisse è un grave lutto per Varie.
Con lui infatti scompare un maestro che domi–
nava il paesaggio figurativo europeo da parecchi
lustri. Egli si è spento a Nizza il
4
novembre
scorso. Era un vegliardo oramai : in dicembre
avrebbe compiuto gli
85
anni. Fino alVultVfno ha
disegnato e dipinto nel suo studio, fino alVultimo
ha conservato il fervore della sua giovinezza.
Quando, poco più che adolescente, dal suo pae*
se natale, Gateau Cambrésis, dov'era nato il
31
di–
cembre
1869,
Matisse, si portò a Parigi, allora la
capitale della Francia era animata dalle pole–
miche sull'impressionismo. Matasse non
tardò
molto a tuffarsi in quel clima vivace e le sue prime
tele dimostrano com'egli accettasse senz'altro i
presupposti della nuova tendenza. Ma già fin da
quel tempo lontano apparve evidente in quale sen–
so egli cercasse di orientare il suo tempera/mento
e la sua intelligenza pittorica: nel senso cioè
della chiarezza e della limpidità del calore.
Ma è nell'epoca
fauve
che Matisse afferma la
propria personalità
bruciando ogni esitazione.
Fauve
vuol dire
belva
e sta ad indicare il movi–
mento di un gruppo di artisti che dal
1904
al
1908
irrompono nel campo dell'arte con inconti–
nenza cromatica, con un gusto violento e spregiu–
dicato nei confronti della pittura precedente.
Questi artisti, tra cui Derain, Braque, Marquct,
Dufy, Vlaminclc, sceglieranno in seguito^ più o
meno, una propria strada fuori dal gruppo, con
maggiore o minore spicco di personalità;
tutta–
via la tavolozza
fauve
in taluni di essi lascia una
traccia profonda che perdura anche nel cammino
t
più calmo della loro storia posteriore. Matisse è
uno di questi; è quello anzi che dalla ricerca dei
fauves
ricava la lezione senza dubbio più sicura.
Il suo
Mar inaio
del
1906,
insieme a qualche altro
quadro dì quell'anno, ne sono una prova. In fondo,
lo sviluppo della pittura di Matisse è proceduto
in questa direzione, approfondendo e affinando,
naturalmente, ogni possibilità implicita in tale
esperienza. Le opere di Matisse, infatti, pur pla–
candosi e distendendosi in piani più larghi e ar–
moniosi di colore, pur trovando in un disegno
unito, scorrevole e continuo, un antidoto ai gridi
cromatici e alle spezzature dei
fauves,
manten–
gono intatta la vena vivace dì quella esperienza,
ne conservano la freschezza, il senso di immedia–
tezza. E queste sono le doti di Matisse: una feli–
cità d'invenzione che ha trovato un'esemplare mi–
sura : un istinto che ha trovato un naturale ri–
gore nella ragione figurativa.
Matisse, infatti^ in mezzo agli estremisnìi del–
l'astrattismo, alle contraddizioni,
all'irraziona–
lismo dell'arte contemporanea sviluppatasi dopo
l'impressionismo, ha sempre opposto una conce–
zione umana dell'arte. « La scelta dei miei co–
lori ~ egli diceva
—
è basata
sìi
W
osservazione*
sul sentimento, sull'esperienza della mia sensibi–
lità ». Egli non ha mai voltato le spalle alla real–
tà. Ogni sua opera è nata da un soggetto, da un
modello. Matisse affermava,
è
vero, che per lui
















